Claustrofobie familiari e amputazioni sembrano il complemento perfetto per il paesaggio afflitto della Germania divisa del dopoguerra fra repressione e devianza, e perfetto è sicuramente Egon Schiele, scelto dall’editore Storie Effimere per la copertina della nuova edizione di questa piccola storia atroce: parliamo di Kuno, capolavoro della tensione e del disgusto firmato dalla “maestra del male” Renate Rasp.
La storia è tanto semplice quanto inquietante: un ragazzo accetta di essere trasformato in albero per compiacere il patrigno.
È con poche parole scelte con cura che Rasp compone la sua storia, inanellando scene minuscole, domestiche, che si susseguono in un crescendo di crudeltà senza mai perdere la patina terrificante dell’ordinarietà più banale.
Il tono è quello pianeggiante della cronaca familiare, perennemente sul punto di volgere verso l’abisso il suo sguardo feroce. Il tutto scorre, comodamente, in un gorgo soffuso di inerzia che diviene ancora più terrificante di fronte all’arrendevolezza dei protagonisti, alla loro insensatezza, alla perversione dei loro progetti perfettamente incasellati in un ménage rigoroso e ripetitivo.

Kuno è un ragazzino qualunque, vive con la madre e lo “zio”, un patrigno dalla psicologia contorta che tiranneggia sulla sua famiglia grazie alla manipolazione e al vittimismo: è suo il ritratto più sconvolgente e riuscito dell’intera opera, che si arricchisce nel procedere della vicenda di dettagli sempre più precisi, concordi e terribili, indizi indispensabili per decifrarne almeno in parte la complessità: l’avarizia con cui dispensa approvazione verso la moglie e il figliastro, l’austerità eletta a forma d’arte, il carisma malsano con cui riesce a trascinare tutti in un deliro collettivo che prende la forma di una pianificazione minuziosa e angosciante.
Il suo progetto è quello di rendere il figliastro Kuno un albero. Per questo ha già compilato pagine e pagine di disegni, proiezioni, tabelle: Kuno avrà il suo posto in giardino, avrà il suo ruolo.
A disturbare il lettore è soprattutto l’analisi – spietata e grottesca al tempo stesso – con cui l’autrice viviseziona i legami familiari che incollano come ragnatele i membri della famiglia: la sudditanza alle bizzarrie dello zio non si basa tanto sulla violenza o su una forma fisica di coercizione, quanto piuttosto su tanti piccoli ricatti morali che nel testo si affastellano sino a disegnare uno scenario da incubo in cui i concetti di bene, di male e di libertà perdono progressivamente di senso.
Lo faccio per il tuo bene, la scelta finale sta a te, sei libero: le parole della manipolazione sono sempre quelle, sono un mantra che penetra nella testa della vittima e la rende arrendevolmente partecipe delle stesse atrocità cui viene sottoposta.

Kuno, con il pretesto di una storia inquietante dalle tinte piacevolmente horror, ci parla però soprattutto di famiglia e di genitori, sollevando il dubbio su quale sia – o dovrebbe essere – il ruolo di un padre o di una madre nel processo di maturazione dei figli.
Il genitore deve guidare, deve nutrire, deve proteggere dalle scelte sbagliate? A quale costo? Qual è il confine fra cura e abuso, dove passa la linea sottile che divide una madre premurosa da una genitrice dispotica?
L’impressione che si ricava da questa lettura – conturbante dalla prima all’ultima pagina – è proprio la sensazione di soffocamento che si proverebbe dentro un abbraccio troppo stretto e troppo prolungato: la famiglia non è mai un ambiente, un fondale, è piuttosto un elemento ingombrante che si prende l’intera scena e anzi sviluppa nella sua quotidianità un microcosmo asfissiante di attenzioni eccessive che si trasformano presto in controllo.
Kuno non sa scegliere, ha bisogno di essere indirizzato, ha bisogno di qualcuno che si preoccupi per lui. Come Renate Rasp, come il Gruppo 47 di cui faceva parte, anche Kuno è l’esito di una sopraffazione sistematica e della collisione fra due generazioni incapaci di dialogare: gli unici esiti possibili sono la rivoluzione o la morte, la fuga da un sistema di contenimento fin troppo affidabile o l’omologazione – definitiva, totalizzante, un letto di Procuste pronto ad amputare mani e piedi e pensieri troppo irriverenti.

Accoppiamenti giudiziosi
Un’artista in particolare ha saputo evocare come Renate Rasp l’ambiguità delle figure parentali dando vita a installazioni di enorme impatto: parliamo di Louise Bourgeois.
L’artista franco-americana, veterana di una carriera lunghissima e molto prolifica, deve la sua fama principalmente alle sue enormi sculture a forma di ragno – figure protettive e predatrici allo stesso tempo – che si ergono da Seoul a Doha agli Stati Uniti tessendo indefesse la loro tela. Sono madri, sono custodi carnivori: le loro zampe arcuate formano una gabbia che è allo stesso tempo segno di protezione e di sopraffazione, mentre il loro ventre rigonfio custodisce e nasconde bianchissime uova di marmo.
L’impatto su chi si imbatte per strada in queste opere mastodontiche non può essere univoco come non può essere univoca e piana l’analisi di una figura così difficile da definire: operosa come un genitore attento, adusa al sacrificio, onnipresente, soverchiante. Non a caso l’emblema del ragno ritorna anche in altri lavori di Bourgeois, in particolare nella serie delle Cells.
Qui l’osservatore si trova a vagare fra ambienti chiusi, gabbie che contengono al proprio interno pezzi d’arredo e sculture, materiali e forme che si rivolgono al sogno e alla memoria così come a una certa forma dolente di speculazione.
Le installazioni di questa serie dunque sono celle ma sono anche cellule, elementi autosufficienti che al loro interno contengono al vita, proteggono e condannano, costruendo attorno ai loro elementi costitutivi una barriera impermeabile.

Ogni gabbia è allestita con attenzione dell’autrice, in un gioco di archeologia personale e di esplorazione onirica che recupera dai propri ricordi elementi familiari e brandelli di storie incomplete: così specchi e sfere, elementi fantastici e quotidiani trovano nella loro cella compimento e perfezione.
Vi sono strane figure appese, profili d’incubo che si stagliano dentro ogni visione serena, oggetti morbidi e taglienti che imprigionano l’osservatore cullandolo nell’illusione di una chiusura salvifica capace di mondare dalle impurità del mondo esterno. Il loro metallo brunito spaventa e soggioga, ma parimenti le gabbie non riescono ad accontentarsi del ruolo di oppressione che sembra loro riservato: la loro complessità morale mette a dura prova l’osservatore, lo prende alla gola mentre miscela reminiscenze d’infanzia e presagi di devastazione. Ogni cella come la famiglia di Kuno è autosufficiente, basta a sé stessa: il progetto che la tiene unita, per quanto assurdo, delirante ed esiziale, è la matrice stessa che compone le sbarre e la dolcezza del suo isolamento. Ogni cosa funziona, nella cellula, ogni cosa ha un compito. Come in ogni famiglia che si rispetti.
La famiglia in questo modo diventa prigione e recinto, spazio sicuro in cui crescere e anche confine che divide irrimediabilmente i suoi membri da chi vive all’esterno.
Ogni gabbia probabilmente ha le sue regole e la sua razionalità incomprensibile dall’esterno, forse per comprenderla appieno bisognerebbe restarci intrappolati almeno per un’infanzia.
Eppure la sensazione che queste opere lasciano – libri o installazioni che siano – è qualcosa di molto difficile da accettare: è attaccamento alle proprie origini, voglia di nido e di comoda reclusione, ma è anche struggimento per la fuga, strangolamento, bisogno insopprimibile di profanare la sicurezza soffocante di un abbraccio che svuota i polmoni per provare a prendere una boccata d’aria e mettere finalmente da soli un passo nell’ignoto.
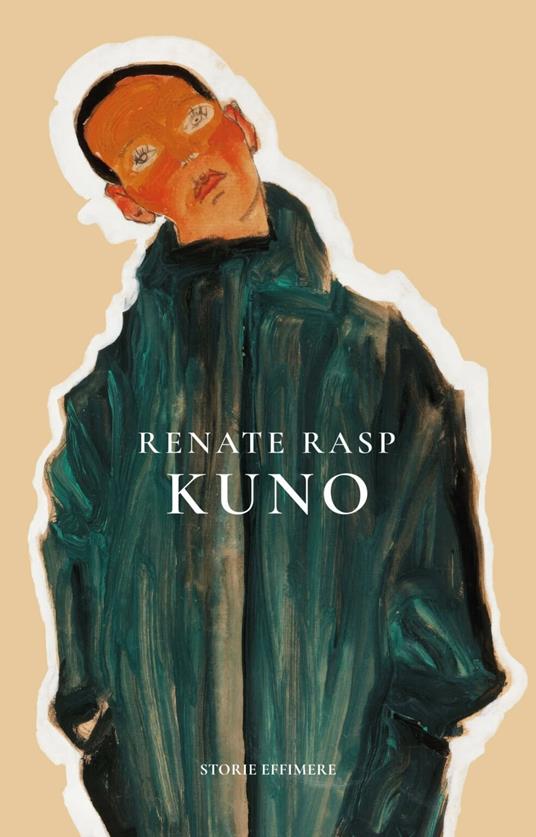
Kuno. Un figlio degenere
Renate Rasp – Storie Effimere, 2025

